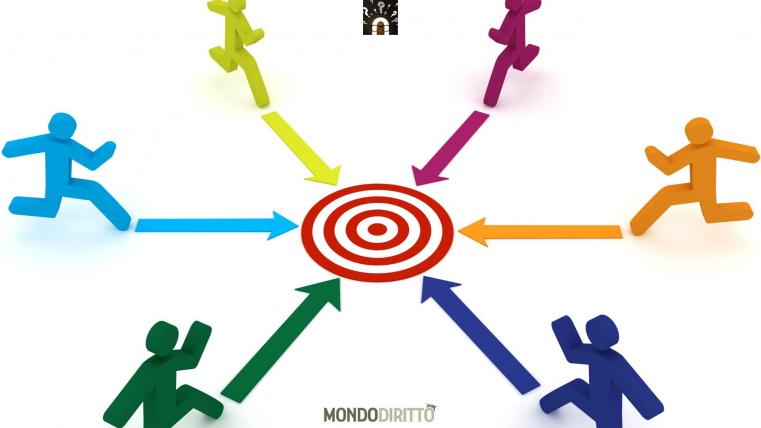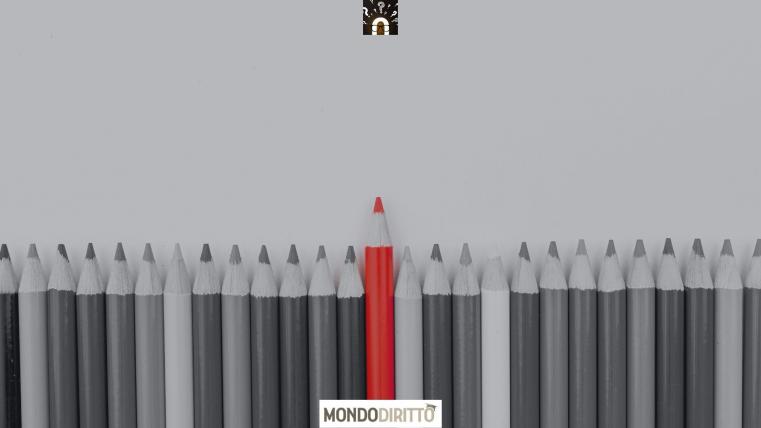Il caso SUPERLEGA (C 333/21) e il mercato europeo delle competizioni di calcio.
A cura dell'Avv. Sandro Marcelli e dell'Avv. Raffaele Troiani. Contributo offerto in collaborazione con Studio Industria.
SOMMARIO:
1. Introduzione: la SUPERLEGA e le possibili sanzioni disciplinari. Questioni pregiudiziali.
2. Il rapporto tra diritto dell'Unione Europea e sport.
3. La tutela della concorrenza nel mercato europeo dell'organizzazione delle competizioni calcistiche.
4. Prospettive future.
1) Introduzione: la SUPERLEGA e le possibili sanzioni disciplinari. Questioni pregiudiziali.
Il caso della Superlega si è rivelato cruciale nel dibattito contemporaneo sulla tutela della concorrenza.
La Superlega, infatti, competizione inizialmente concepita per apportare nuova linfa finanziaria ai principali club calcistici europei nel periodo pandemico e post pandemico, si è trasformata rapidamente in un caso giuridicamente complesso, soprattutto in relazione al delicato bilanciamento tra il diritto comunitario, in specie la normativa a tutela della concorrenza, e le specificità del fenomeno sportivo (in questo caso, il calcio). Tale contributo si pone dunque l’obiettivo di esaminare il delicato equilibrio tra la tutela della concorrenza e le peculiarità del contesto sportivo, per come definito nel tempo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (d’ora in avanti, la Corte) attraverso importanti leading case.
Prima di esaminare le questioni pregiudiziali affrontate dalla Corte, è importante capire il contesto in cui si cala il dibattito, ossia l'annuncio del progetto Superlega nell’aprile 2021. Tale iniziativa prevedeva la creazione, in Europa, di una nuova competizione internazionale per i club calcistici più prestigiosi, parzialmente chiusa alle ordinarie e tradizionali logiche fondate sul meccanismo del c.d. merito sportivo. A causa di questa caratteristica, il progetto ha subito sin da subito forti critiche, da parte di addetti ai lavori e non, in quanto percepito come una minaccia ai valori fondamentali dello sport.
La Fifa e la Uefa, in primis, quali istituzioni apicali nella gestione del calcio a livello internazionale (rispettivamente mondiale ed europeo), hanno minacciato sanzioni ed esclusioni contro le società e gli atleti coinvolti nel caso in cui avessero deciso di portare avanti tale iniziativa.
In risposta a tali minacce, la società fondatrice della Superlega ha presentato ricorso al Tribunale di Madrid, sostenendo che le azioni di Fifa e Uefa si ponessero quali violazioni della normativa europea in materia di concorrenza.
Il Tribunale ha così deferito alla Corte di Giustizia le questioni riguardanti l'applicazione degli articoli 101 e 102 del TFUE (1) .
Nello specifico, tali norme vietano le intese restrittive della concorrenza e l’abuso di posizione dominante.
È bene anticipare che, la sentenza della Corte, pubblicata nel dicembre 2023, chiarisce la portata delle condotte di Uefa e Fifa nel contesto della normativa comunitaria, senza tuttavia pronunciarsi sulle specifiche del progetto Superlega: nel dettaglio, i temi affrontati riguardano, infatti, la portata dei poteri attribuiti alle istituzioni sopra menzionate (rectius, auto-attribuitisi da tali istituzioni), nonché, di estrema rilevanza, le modalità del relativo esercizio.
2) Il rapporto tra diritto dell'Unione Europea e sport.
Occorre ricordare che il calcio nasce come un gioco, un’innocente passione popolare, divenendo progressivamente lo sport più seguito e praticato del continente europeo. In tale ambito, ha sviluppato nel tempo una dimensione comunitaria, connotata da tradizioni e valori uniformi, oltre ad assumere funzioni di interesse pubblico a carattere sociale, educativo e culturale.
Un modello sportivo europeo la cui sopravvivenza postula la salvaguardia delle specificità che lo contraddistinguono (2) , la quale, a sua volta, presuppone che tutte le competizioni continentali si svolgano secondo regole e principi comuni. Di qui, l’esigenza di affidare la regolamentazione ed il governo del settore sportivo alla direzione di un unico organismo apicale per ogni contesto geografico.
Complice la dimensione settoriale e tecnica, nonché originariamente non economica, delle attività in questione, bisognose di essere gestite da enti dotati di specifiche competenze ed esperienze (3), gli ordinamenti giuridici, nazionali ed internazionali, hanno accettato, nel tempo, di riconoscere autonomia all’ordinamento sportivo(4).
Il calcio, nello specifico, ha visto crescere una realtà ordinamentale, di dimensione internazionale, a struttura piramidale (5) , le cui posizioni apicali, a livello mondiale ed europeo, sono rivestite dalla Fifa e dalla Uefa, Federazioni sportive che operano come “associazioni di diritto privato responsabili dell’organizzazione e del controllo del calcio”.
Una funzione direttiva ed organizzativa che, unita alla loro autonomia giuridica, le rende “autorizzate ad adottare, ad applicare e a far rispettare norme relative all’organizzazione e allo svolgimento delle competizioni internazionali”(6) . Tuttavia, nell’ambito di questo processo di crescita, il gioco del calcio, soprattutto nel corso degli anni ’90 (7) , è divenuto un vero e proprio business di dimensione internazionale. Una realtà industrializzata di cui la competizione sportiva e quella economica sono momenti indissolubili, per quanto diversi. Un settore costituito, per giunta, da molteplici mercati. Ad un mercato principale ed orizzontale, avente ad oggetto le attività di organizzazione e commercializzazione delle competizioni (8) , si sono aggiunti mercati secondari, derivati e verticali, concernenti lo sfruttamento di tutti i diritti collegati agli eventi medesimi (9) . Di conseguenza, il calcio, che nella sua originaria natura sportiva fuoriusciva dalle attribuzioni della Comunità Europea, ha finito per acquisire una grande rilevanza economica, tale da farlo ricadere nel campo di applicazione delle norme dei Trattati a tutela del mercato interno, dunque della concorrenza e delle libertà di circolazione e prestazione dei servizi(10) .
Un’evoluzione molto rilevante, suscettibile di intaccare l’autonomia dell’ordinamento calcistico, nonché dei suoi organi di governo, esponendone le regole e le decisioni al sindacato della giurisprudenza europea, ispirato, prioritariamente, alla salvaguardia delle esigenze di mercato piuttosto che alla tutela dei valori sportivi. Cambiamenti nei quali le stesse Istituzioni europee, come emerso in diverse iniziative politiche (11) , hanno ravvisato minacce per la preservazione delle specificità e delle poliedriche funzioni del settore sportivo, ritenendo altamente rischiosa, in particolare, la sua eventuale equiparazione ad ogni altro settore economico (12) . Si è quindi invocata, a più riprese, l’esigenza di tener conto delle peculiarità del calcio in sede di applicazione del diritto comunitario, salvaguardando, altresì, l’autonomia dell’Ordinamento sportivo e dei suoi organismi di governo. Del resto, si può ritenere che il nodo cruciale della vicenda Superlega sia proprio il confronto-scontro tra anime diverse di uno stesso settore, la cui coesistenza impone un contemperamento inevitabile tra le relative esigenze.
La questione centrale, dunque, è il modo di bilanciarle.
Ebbene, la prima soluzione a cui ha tentato di ricorrere la Corte, nell’ambito di un filone interpretativo sviluppatosi fin dagli anni ’70, al fine di dare rilevanza alle peculiarità sportive nell’applicazione delle norme comunitarie a tutela del mercato, è consistita nel perimetrare, caso per caso, i confini di un’ipotetica eccezione sportiva, composta da regole e discipline che, rispondendo ad esigenze e finalità inerenti al funzionamento dello sport come tale, scevre da considerazioni economiche, siano da ritenersi del tutto esenti dall’applicazione del diritto europeo (13) . Si tratta, tuttavia, di un criterio derogatorio piuttosto generico, aggravato dal rapporto di proporzionalità inversa tra l’ampiezza dell’eccezione e la portata applicativa di norme comunitarie di rango primario, tanto da condurre la Corte, fin dai primi arresti in materia, a precisare che l’eccezione medesima “non può essere invocata per escludere un’intera attività sportiva dalla sfera d’applicazione del Trattato”(14) . Tali criticità hanno raggiunto un punto di rottura nella causa Meca-Medina, del 2006 (15) , all’esito della quale la Corte ha evidenziato come, dal momento che un’attività sportiva ricade nel campo di applicazione del diritto europeo, debba valutarsi la conformità allo stesso delle regole che ne condizionano e limitano l’accesso. Inoltre, quand’anche tali regole siano puramente sportive, così da sfuggire all’applicazione delle norme a tutela delle libertà di circolazione, si pone egualmente la necessità di verificare la compatibilità con le norme a tutela della concorrenza, rispetto alle quali, evidentemente, l’eccezione sportiva ha perso rilevanza derogatoria(16) .
L’esigenza di un bilanciamento, tuttavia, è apparsa ancora più evidente a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che, per la prima volta, ha dato riconoscimento normativo di rango primario, nell’articolo 165 TFUE, ad una “dimensione europea dello sport”, connotata da valori e specificità costitutive, attribuendo esplicitamente all’Unione il compito di tenerne conto (17) . Dunque, si potrebbe sostenere, come fatto dall’Avvocato generale nelle sue conclusioni sulla causa Superlega (18) , che l’articolo 165 TFUE valga a giustificare un trattamento differenziato del settore sportivo.
In primo luogo perché, in nome del criterio di specialità, si potrebbe ravvisare nell’articolo in questione, in quanto relativo a specifiche attività, la norma in conformità alla quale interpretare ed applicare le regole generali sul mercato. In secondo luogo, perché l’articolo 7 TFUE impone coerenza e coordinamento tra le politiche interne dell’Unione Europea. Tuttavia, la Corte, nella sentenza in commento, disconosce la validità di tali presupposti teorici. Difatti, interpretando l’articolo 165 come norma di attuazione dell’articolo 6, lett. e, TFUE, e valorizzando il tenore letterale e la collocazione sistematica, è giunta a ritenere che il primo dei due non contenga una norma “orizzontale”, ossia ad applicazione trasversale, e non valga ad individuare una nuova politica interna dell’Unione Europea, a cui dover coordinare le altre. Viceversa, l’articolo 165 si limita ad autorizzare un’azione dell’Unione, in settori specifici ed entro certi limiti, con il solo obiettivo di sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri nei medesimi settori. Ben diversa è la valenza sistematica che rivestono, nell’Ordinamento dell’Unione Europea, le norme del Trattato a tutela del mercato interno (19) . Di conseguenza, la Corte ha escluso la possibilità di considerare l’articolo 165 TFUE una norma speciale che giustifichi un trattamento particolare dello sport.
Una conclusione che può ritenersi emblematica di una più ampia impostazione interpretativa della Corte, che, in linea con le considerazioni espresse fin dalla causa Meca-Medina, tende a negare alle specificità dello sport, che pure riconosce come innegabili, la capacità di giustificare, già in astratto, alcuna eccezionale restrizione applicativa delle norme a tutela delle libertà economiche dei privati nel mercato interno. Di conseguenza, come ribadito nella sentenza sul caso Superlega, tali specificità “possono eventualmente essere prese in considerazione”, se pertinenti, solo ed esclusivamente “nel quadro e nel rispetto delle condizioni e dei criteri di applicazione” delle norme a tutela della concorrenza, senza poter beneficiare, anche in concreto, di alcun trattamento differenziato o modulato (20) .
3) La tutela della concorrenza nel mercato europeo dell'organizzazione delle competizioni calcistiche.
In coerenza con quanto visto, nella causa Superlega la Corte è stata chiamata a verificare se i divieti imposti agli operatori del mercato dalla disciplina comunitaria antitrust, dunque dagli articoli 101 e 102 TFUE, possano ritenersi violati, alla luce delle loro ordinarie e generali condizioni di applicazione, da disposizioni adottate da Fifa e Uefa in qualità di organi di governo del calcio mondiale ed europeo (21) .
Nello specifico, indizi di incompatibilità connotano quelle norme con cui le Federazioni, oltre a riconoscersi il compito di provvedere direttamente all’organizzazione e commercializzazione di competizioni calcistiche internazionali in Europa, si riservano il potere di decidere se autorizzare l’istituzione ed organizzazione, ad opera di terzi, di competizioni parallele, vietando ai club e calciatori affiliati, a pena di sanzioni disciplinari, di partecipare a partite o tornei internazionali che la Fifa e la Uefa non abbiamo né organizzato né autorizzato.
Occorre comprendere, dunque, se l’adozione ed applicazione di simili disposizioni statutarie violino, innanzitutto, il divieto di intese restrittive della concorrenza, sancito dall’articolo 101, par. 1, TFUE, ai fini della cui integrazione è sufficiente che i comportamenti delle imprese sul mercato siano coordinati in forma “istituzionale”, ossia per il tramite di strutture collettive ed organi comuni. Orbene, la Corte, nel corso del tempo, ha consolidato il convincimento per cui il concetto di impresa, ai fini del diritto della concorrenza, deve essere inteso come nozione comunitaria, valevole uniformemente per tutti gli Stati membri, prescindendo dai singoli diritti nazionali, così da riguardare “qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento”(22) .
Si tratta, dunque, di una nozione sostanziale e funzionale, collegata esclusivamente alla natura dell’attività posta in essere, la quale è “economica” ogniqualvolta “consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato”(23) . Non rileva altro, né la forma giuridica del soggetto, né la sua organizzazione e neppure le finalità perseguite (24) .
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE, dunque, appare sufficiente ricordare come le Federazioni calcistiche internazionali siano associazioni di diritto privato che riuniscono, in qualità di membri diretti, le federazioni nazionali, oltreché, in via indiretta, i club ad esse affiliati. Questi ultimi, soprattutto se di livello professionistico o semiprofessionistico, possono essere qualificati come imprese in quanto “società che esercitano economicamente il gioco del calcio”(25) . I club sono membri delle Federazioni calcistiche nazionali, le quali, oltre ad essere, di conseguenza, associazioni di impresse, possono ritersi imprese nella misura in cui espletano l’attività economica dell’organizzazione e commercializzazione delle competizioni di calcio a livello statale.
È conseguenza logica di tale ricostruzione che, al vertice della struttura piramidale del calcio internazionale, la Fifa e la Uefa operino, quantomeno, come associazioni di imprese. Dunque, si può ritenere che l’adozione ed applicazione di disposizioni statutarie, attributive di poteri che consentono il controllo dell’accesso al mercato dell’organizzazione, nonché della partecipazione alle competizioni, siano deliberazioni di enti associativi, atte a coordinare e conformare, nell’ambito del mercato interno europeo, le attività economiche delle imprese affiliate. Ne deriva che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, par. 1, TFUE, possono ritenersi “decisioni di associazioni di imprese”, suscettibili, in virtù del loro contenuto e della loro portata, di incidere, anche in senso pregiudizievole, sul “commercio tra Stati membri”(26) .
Ben più complesso è l’accertamento che riguarda l’integrazione dell’ulteriore presupposto di applicazione del divieto di cui all’articolo 101, par. 1, TFUE, ossia la configurabilità di una decisione che abbia “per oggetto” o “per effetto” di impedire, restringere o falsare il funzionamento concorrenziale del mercato interno. Come chiarito ripetutamente dalla Corte, l’uso della congiunzione “o” palesa un’alternatività tra queste due condizioni, giustificata anche da un diverso regime probatorio, che impone di verificare preliminarmente l’eventuale sussistenza di un oggetto restrittivo.
A tal riguardo, la Corte ha precisato, in più occasioni, che la nozione di restrizione per oggetto può considerarsi integrata solamente da forme di coordinamento tra imprese che rivelino, “per la loro stessa natura”, un grado di dannosità per la concorrenza tale da potersi ritenere, pacificamente, che la probabilità che ne derivino effetti negativi sia talmente elevata da renderne inutile la verifica in concreto (27) .
La Corte ha chiarito, inoltre, come i parametri da considerare, al fine di valutare la sussistenza di tali presupposti, siano il tenore della decisione, il contesto economico-giuridico in cui si inscrive e gli obiettivi oggettivamente perseguiti, ossia le finalità manifestate dalle decisioni, in sé e per sé considerate (28) .
Orbene, le disposizioni controverse, di cui si è ricordato il contenuto essenziale, si inscrivono in un contesto in cui, da decenni, la Fifa e Uefa, data l’assenza di concorrenti, si occupano da sole delle attività economiche di organizzazione e sfruttamento commerciale delle competizioni interclub europee, ottenendo ingenti ritorni economici.
È intuibile, dunque, come la scelta di affiancare all’esercizio monopolistico di remunerative attività economiche, la titolarità del potere di decidere se e a quali condizioni consentire ad altre imprese di accedere al medesimo mercato, possa generare un conflitto di interessi, a fronte del quale l’esercizio del potere autorizzatorio, oltreché sanzionatorio, potrebbe essere piegato al conseguimento di interessi economici egoistici.
Un rischio aggravato dalla mancanza, nella disciplina statutaria delle Federazioni sovranazionali, di regole sostanziali e procedurali atte ad imporre il rispetto di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, idonei a scongiurare il pericolo di un esercizio abusivo dei poteri richiamati. È anche vero che la Corte, quando si è trovata ad applicare l’articolo 101 a norme con cui un’associazione di imprese, allo stesso tempo organismo di regolamentazione ed operatore economico del mercato, si dota di un illimitato potere preclusivo dell’accesso di concorrenti, ha evidenziato l’esigenza di valorizzare, altresì, gli obiettivi che oggettivamente motivano le disposizioni (29) .
Circa le previsioni statutarie coinvolte nel caso Superlega, appare possibile ritenere che la finalità di abusare dei poteri per egoistici interessi economici sia meramente soggettiva ed eventuale. Esse, piuttosto, come riconosciuto nella sentenza in commento (30) , mirano, nella loro oggettività e chiarezza, a predisporre un meccanismo, reso effettivo dalla minaccia di sanzioni, di controllo preliminare della conformità di nuove competizioni internazionali ai principi costitutivi del modello sportivo europeo, consacrati dall’articolo 165 TFUE, il che, come anticipato, può ritenersi essenziale al fine di salvaguardarne le specificità e le funzioni di interesse generale.
Si deve considerare, inoltre, che il rispetto delle norme e decisioni della Fifa e della Uefa non è imposto, con norme di diritto pubblico, né da uno Stato né dall’Unione Europea, cosicché non vi è alcun impedimento, sul piano giuridico ed astratto, che precluda l’organizzazione di competizioni indipendenti, sganciate dal loro controllo.
Sulla base di tali considerazioni, dunque, si potrebbe arrivare a sostenere che le disposizioni statutarie di cui si tratta, pur sollevando indizi di effetti anticoncorrenziali, dato che consentono ad imprese dominanti di impedire discrezionalmente l’accesso di concorrenti nel mercato, non hanno per oggetto, nella loro astrattezza e per loro natura, di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno dell’organizzazione delle competizioni calcistiche.
Proprio in questa prospettiva, infatti, l’Avvocato generale è giunto a suggerire, nelle sue conclusioni, che “solo un’analisi concreta dell’esercizio del potere discrezionale” consentirebbe di stabilire se ne sia stato fatto, nel caso specifico, “un uso discriminatorio e inappropriato”, così da confermare, “sulla base di un’analisi approfondita”, gli indizi di effetti anticoncorrenziali (31) . Non è stato questo, però, l’iter logico seguito dalla Corte, la quale ha fatto leva su una serie di precedenti in cui si è consolidato il principio per cui, dato che “un sistema di concorrenza non falsata può essere garantito solo se siano garantite pari opportunità tra i vari operatori economici”, le misure con cui gli Stati membri concedono ad un’impresa diritti speciali o esclusivi, conferendole un “evidente vantaggio sui concorrenti”, si pongono in contrasto, in sé e per sé, con le norme del Trattato, in quanto creino un rischio di abuso dei poteri che ne derivano, de iure o de facto, a prescindere che l’abuso si verifichi effettivamente (32) .
Di conseguenza, affinché possano considerarsi compatibili con la disciplina antitrust, è essenziale che simili misure fissino “limiti, obblighi o controlli”, idonei a neutralizzare il rischio che l’impresa “possa falsare la concorrenza”(33) . Ebbene, sembra potersi dire che la Corte abbia applicato appieno tali principi al caso Superlega, nonostante le differenze, in punto di vincolatività e di rilievo giuridico, rispetto ai diritti speciali o esclusivi di fonte legale, gli unici ai quali, tra l’altro, è applicabile l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE. Difatti, la Corte è giunta a ritenere che le disposizioni statutarie controverse abbiano un oggetto anticoncorrenziale, nella loro astrattezza, in quanto, data l’assenza di condizioni sostanziali e procedurali che ne rendano oggettiva e trasparente l’attuazione, consentono alle Federazioni calcistiche di negare arbitrariamente ed irragionevolmente a terzi l’organizzazione di competizioni parallele (34) .
Un oggetto anticoncorrenziale che è rafforzato dalle norme sul controllo e sulla sanzione della partecipazione di club e giocatori, in quanto tali da produrre un effetto dissuasivo rispetto all’ingresso nel mercato. Si è ritenuto, in altri termini, che tutte le disposizioni in questione presentino, per loro stessa natura, una dannosità per la concorrenza tale da impedirla per oggetto (35) .
Un approccio che la Corte ha confermato anche in sede di valutazione del loro rapporto con l’articolo 102 TFUE, che vieta comportamenti unilaterali di impresa, tali da integrare uno sfruttamento abusivo di una sua posizione dominante sul mercato. A tal riguardo, non vi è dubbio sul fatto che la Fifa e la Uefa siano, in senso funzionale, imprese che detengono una posizione dominante sul mercato dell’organizzazione e commercializzazione delle competizioni in Europa, considerato che è un mercato orizzontale, cioè tale da coinvolgere solo gli organizzatori, e che, come detto, le Federazioni in questione non hanno concorrenti (36) .
Un profilo meno scontato, seppur non approfondito in sentenza, è se la Fifa e la Uefa possano considerarsi imprese anche nel compimento delle attività oggetto di sindacato nel caso di specie. Difatti, la Corte, con approccio funzionale, è giunta a ritenere, in precedenti arresti, che un soggetto possa considerarsi impresa solo in relazione alle sue attività economiche, di offerta di beni o servizi nel mercato, non anche per quelle attività che ponga in essere nell’esercizio di prerogative tipiche dei pubblici poteri, con finalità di interesse generale (37) .
Dunque, con riguardo alla causa in commento, potrebbe sostenersi che la Fifa e la Uefa, nel momento in cui, come autonomi organi di governo del calcio mondiale ed europeo, predispongono ed esercitano poteri e meccanismi essenziali affinché le competizioni calcistiche funzionino correttamente e soddisfino i valori costitutivi di un comune modello europeo, riconosciuto dal Trattato, espletano funzioni e prerogative di interesse generale, dunque sostanzialmente pubbliche, prive di una propria dimensione economica.
Complice l’assenza di una definizione generale e formale di pubblica amministrazione, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo, si potrebbe ritenere che, nell’adottare ed applicare le disposizioni statutarie controverse, le Federazioni calcistiche non compiano attività economiche, dunque non operino come imprese (38) , così da sfuggire, in ordine a tali attività, all’applicazione dell’articolo 102 TFUE. Tuttavia, argomentazioni contrarie sono ricavabili da precedenti arresti della Corte, da cui è possibile desumere, innanzitutto, come la ragione che impedisce di individuare un’impresa in relazione all’esercizio di prerogative tipiche dei pubblici poteri risiede nell’assenza di incidenza sulla sfera degli scambi economici (39) . Orbene, è possibile sostenere che una normativa come quella di Fifa e Uefa, che condiziona e limita l’accesso al mercato di operatori concorrenti, nonché la partecipazione ad attività lucrative da parte di club e calciatori, abbia un impatto notevole sugli scambi economici.
Sarebbe difficile, peraltro, scindere l’attività di organizzazione delle competizioni dall’attività, compiuta dallo stesso operatore, di gestione e controllo delle stesse.
Motivo per cui un soggetto di diritto privato, quali sono la Fifa e la Uefa, che opera nel mercato come impresa, soggiace ai vincoli imposti dal diritto europeo della concorrenza anche in ordine a quella parte di attività con cui, mediante altri mezzi e poteri, ostruisce l’accesso di concorrenti, dal momento che le prerogative in questione non sono oggetto di un’attribuzione, regolamentazione o limitazione di diritto pubblico(40) . Del resto, è prevalente il convincimento per cui non si possa individuare una tale investitura neppure nell’articolo 165 TFUE, che si limita a riconoscere l’esistenza e l’importanza di “organismi responsabili dello sport”, omettendo di identificarli e di conferirgli poteri. Resta da capire se l’adozione delle disposizioni controverse integri, in sé e per sé, uno sfruttamento abusivo di posizione dominante.
A questo proposito occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza europea, la nozione di posizione dominante corrisponde ad una situazione di potenza economica, tale da consentire all’impresa di ostacolare, con comportamenti indipendenti, il corretto funzionamento concorrenziale del mercato (41) .
Viceversa, l’articolo 102 TFUE vieta solamente quei comportamenti dell’impresa dominante che “abbiano l’effetto di ostacolare”, ricorrendo a mezzi diversi da quelli propri di una competizione basata su merito ed efficienza, la conservazione o lo sviluppo della concorrenza ancora esistente sul mercato (42) .
Si tratta, evidentemente, di una “nozione oggettiva”, il cui riscontro deve avvenire alla luce di tutte le specifiche “circostanze di fatto pertinenti”(43) . Sulla base dei parametri illustrati, si potrebbe ragionare, come sostenuto dall’Avvocato generale nelle sue conclusioni (44) , nel senso che la situazione sostanzialmente monopolistica di mercato, unita all’autoattribuzione di poteri di controllo sullo stesso, oltreché all’assenza di criteri sostanziali e procedurali atti a delimitarne l’esercizio, conferisca a Fifa e Uefa la capacità di ostacolare, con mezzi diversi da quelli propri di una competizione meritocratica, la concorrenza effettiva e leale sul mercato dell’organizzazione e commercializzazione delle competizioni calcistiche europee.
Una tale capacità, però, integrerebbe, in sé e per sé, solo gli estremi di una posizione dominante, seppur a forte rischio di abuso. Piuttosto, sarebbe necessario guardare al modo in cui quei poteri siano effettivamente esercitati, accertando se ne venga fatto, o meno, un impiego distorto e distorsivo, da cui, eventualmente, scaturiscano effetti anticoncorrenziali, verificando, in particolare, se i terzi siano indebitamente ed irragionevolmente privati dell’accesso al mercato.
Viceversa, la Corte ha ritenuto, anche in tal caso, di applicare appieno, in via analogica, i principi elaborati in ordine alle misure pubblicistiche che, conferendo all’impresa poteri illimitati sui concorrenti, generino un rischio di abuso.
In questa prospettiva, l’autoattribuzione, da parte di un’impresa dominante, di poteri che le consentono di controllare l’accesso al mercato di potenziali concorrenti, integra, in sé e per sé ed in ogni caso, una violazione dell’articolo 102 TFUE, qualora quei poteri non siano assoggettati, come nel caso di specie, a limiti, obblighi e controlli atti ad escludere, alla radice, il rischio di un loro sfruttamento abusivo (45) . Or dunque, si potrebbe constatare come la Corte, nel compiere tale operazione analogica in modo indiscriminato, senza operare alcuna distinzione, neppure a seconda del modo o delle ragioni per cui l’impresa si dota di certe prerogative, dimostra di non valorizzare, innanzitutto, la differenza di impatto sul mercato che, in astratto, connota poteri di cui il diritto pubblico impone il rispetto. Tale approccio potrebbe apparire critico anche perché, come detto, la possibilità di considerare illegittime le misure statali per il solo fatto di generare un rischio di abuso, si giustifica ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, il quale, però, si riferisce solo alle misure degli Stati membri e presenta un tenore diverso da quello dell’articolo 102 TFUE, che, di per sé, vieta la concretizzazione di quel rischio.
Si potrebbe rilevare, inoltre, un profilo di contraddittorietà del descritto iter argomentativo, in quanto: o la Fifa e la Uefa, anche nella adozione ed applicazione delle proprie normative, sono imprese che si attribuiscono ed esercitano poteri privati, che quindi non dovrebbero essere trattati alla stregua di poteri autoritativamente conferiti da norme di diritto pubblico, oppure tale equiparazione è possibile e ragionevole. Questa seconda alternativa, che appare attuata dalla Corte, potrebbe consentire di sostenere, tuttavia, che la Fifa e la Uefa, nell’adottare ed applicare le disposizioni statutarie in questione, esercitano prerogative assimilabili a potestà di diritto pubblico, dunque non operano come imprese e, di conseguenza, non possono soggiacere, per quanto riguarda tali attività, al divieto imposto dall’articolo 102 TFUE.
Al contempo, si deve comunque tenere conto del fatto che la Corte, in qualità di Istituzione nomofilattica dell’ordinamento comunitario, è chiamata ad interpretare ed applicare il diritto dell’Unione Europea nel rispetto del rapporto gerarchico e sistematico dei principi, valori ed obiettivi da esso riconosciuti. Nella vicenda in questione, la Corte appare operare in coerenza con l’interpretazione, da lei sposata, secondo cui la salvaguardia delle esigenze proprie del mercato interno rappresenta, per l’ordinamento sovranazionale, un obiettivo prioritario rispetto alla tutela del modello sportivo europeo (46) , richiamato esclusivamente dall’articolo 165 TFUE, che si limita ad autorizzare un’azione di coordinamento, sostegno e completamento in favore degli Stati membri. Il rischio, però, è che il settore calcistico, in virtù della sua dimensione commerciale, riceva dall’Unione Europea un trattamento identico a quello pensato dal Trattato per qualunque altro settore economico, nonostante le innegabili specificità e differenze insite nella natura del primo, con il connesso pericolo di compromettere la sopravvivenza dell’anima extra-economica del modello sportivo europeo (47) .
In altri termini, il rischio di un approccio giurisprudenziale tanto rigido è che, tra le esigenze del mercato interno, prioritarie per il Trattato, e l’obiettivo di proteggere la dimensione comunitaria dello sport, per come riconosciuta dall’articolo 165 TFUE, non ci sia alcuna forma, neppure minima, di bilanciamento. Difatti, le soluzioni raggiunte dalla Corte impediscono anche l’operatività di quel filone giurisprudenziale, sviluppatosi sulla base della c.d. teoria delle restrizioni accessorie, che consente di escludere, alla radice, una violazione dell’articolo 101 TFUE, senza bisogno di ricorrere all’esimente prevista dal paragrafo 3, ove gli effetti anticoncorrenziali dell’atto siano giustificati, in quanto inerenti e proporzionati rispetto al conseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale (48) . Invero, anche la sola possibilità di ragionare in ordine alla soddisfazione di tali condizioni da parte degli effetti preclusivi, derivanti dal meccanismo autorizzatorio controverso (49) , risulta preclusa dalla posizione della Corte, in quanto la giurisprudenza sulle restrizioni accessorie normative e sportive, come emerge dai relativi arresti, non può trovare applicazione nei confronti di decisioni che, come ritenuto per le disposizioni di Fifa e Uefa, abbiano per oggetto di impedire o falsare la concorrenza ed integrino, in sé e per sé, un abuso di posizione dominante. Di conseguenza, si può rilevare come, a causa del rigido approccio interpretativo adottato dalla Corte nella causa in commento, l’esigenza di tener conto delle specificità dello sport finisca, di fatto, per rimanere disattesa anche nell’unico contesto in cui l’Istituzione giudiziaria ammette la loro valorizzazione, ossia quello dell’accertamento, in concreto, dei presupposti applicativi dei vincoli imposti dal Trattato a tutela della concorrenza nel mercato.
A maggior ragione, evidentemente, appare altamente improbabile che i soggetti coinvolti riescano a dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni costitutive dell’esimente ammessa dal paragrafo 3 dell’articolo 101 TFUE (50) , nonché della giustificazione oggettiva che, per ragioni di coerenza sistemica, la giurisprudenza mutua in relazione all’articolo 102 TFUE (51) . Invero, soprattutto nella misura in cui tali eccezioni esigono che la misura restrittiva sia indispensabile per la produzione di oggettivi e significativi vantaggi per tutti gli utilizzatori del mercato, nonché tale da non consentire, neppure in potenza, l’eliminazione totale o maggioritaria della concorrenza, ne appare compromessa l’integrazione in virtù della mancata previsione, negli Statuti di Fifa e Uefa, di condizioni sostanziali e procedurali che, garantendo un esercizio oggettivo, trasparente e ragionevole dei poteri autorizzatori e sanzionatori, potrebbero impedire inutili ed infondate limitazioni anticoncorrenziali.
4) Prospettive future.
È dunque evidente, in riferimento a quanto sinora esaminato, come la portata della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia risulti, senza dubbio, di primaria importanza. Infatti, nell’alveo delle argomentazioni di cui ai precedenti paragrafi, si possono cogliere alcuni spunti particolarmente rilevanti per le prospettive future del rapporto, e conseguente necessario bilanciamento, tra normativa a tutela della concorrenza (rectius, normativa comunitaria in generale) e sport.
Sul punto, la sentenza potrebbe, in primo luogo, avere l’effetto dirompente di facilitare l’ingresso di competizioni create ad iniziativa delle singole società, così da moltiplicare casistiche simili alla Superlega, senza sapere, soprattutto, se potrà esserci un sindacato nel merito del rispetto dei valori e principi fondanti il fenomeno sportivo (come anticipato, la sentenza della Corte nulla dice circa le questioni afferenti alle concrete caratteristiche del progetto Superlega). Tuttavia, a ben vedere, la stessa sentenza potrebbe anche rappresentare un monito, rivolto a FIFA e UEFA (ma non solo, in quanto il ruolo di tali istituzioni è rivestito, in altri ambiti sportivi, da soggetti aventi poteri della stessa specie) (52 , funzionale all’introduzione, a livello statutario, di norme chiare circa condizioni e modalità di esercizio di tali poteri. Si potrebbe pensare di introdurre, ad esempio, norme procedimentali funzionali all’approvazione preventiva, arricchite da ulteriori specifiche circa le modalità di esercizio di tali poteri, in grado di eliminare il carattere discrezionale e/o arbitrario insito nel quadro regolamentare che attualmente presiede l’organizzazione delle competizioni sportive nel mondo del calcio. Ancora, invocando la dimensione europea dello sport, si potrebbe prevedere la possibilità di impedire a monte l’organizzazione di competizioni che non rispettano determinati principi e valori, così da rimettere ad un giudizio concreto l’eventuale sussistenza di condizioni che giustifichino il ricorso a tali misure, oggettivamente restrittive della concorrenza.
Ulteriore possibilità è che le fattispecie controverse, relative all’istituzione di nuove e parallele competizioni, siano risolte in via pattizia, di volta in volta, ad opera delle Federazioni e dei terzi organizzatori, trattandosi di soggetti di diritto privato, senza alcuna modifica delle regole statutarie esistenti.
Ad ogni modo, quali che dovessero essere gli sviluppi futuri sul caso Superlega, è evidente come la portata della sentenza emessa dalla Corte inciderà profondamente (o, forse, ha già inciso) sul complesso bilanciamento tra tutela della concorrenza (quale branca del diritto concretamente interessata in questo caso) e specificità dello sport, di fatto aprendo le porte a scenari imprevedibili e, potenzialmente, ad una nuova concezione dello sport, non più fondata sulle regole granitiche che si sono imposte sino ad oggi in Europa.
NOTE
1 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Tribunale di commercio di Madrid, Spagna), con decisione dell’11 maggio 2021.
2 Basti pensare a come l’attrattività delle competizioni calcistiche dipenda dall’incertezza del risultato, quindi da un equilibrio competitivo, che richiede un sistema ispirato a valori di pari opportunità e meritocratica, ma anche ad una logica di solidarietà finanziaria di tipo redistributivo, tale per cui tutte le società in competizione, a prescindere dalla loro dimensione e dal loro seguito, possano costruire squadre in grado di “giocarsela” con le realtà più blasonate e ricche. Del resto, se fosse scontato il risultato della competizione, nessuno avrebbe più interesse ad assistervi.
3 In tal senso, Sentenza Corte giust., 11 aprile 2000, Deliège, C 51/96 e C 191/97, EU:C:2000:199, pp.67 e 68; si veda anche sentenza Corte giust., 13 giugno 2019, TopFit e Biffi, C 22/18, EU:C:2019:497, p.60.
4 Anche il legislatore italiano, con l. 280/2003 (di conversione del D.l. n. 220 del 19/08/2003) ha espressamente riconosciuto l’autonomia dell’Ordinamento sportivo, riservandogli la disciplina di svariate questioni settoriali, “al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive”, anche attraverso l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
5 Circa la struttura dell’ordinamento sportivo si veda, ex prulimis, Corte giust., 15 dicembre 1995, Bosman, C 415/93, EU:C:1995:463, pp.3 e 4.
6 Si vedano, in tal senso, punti 75, 82 e 142, della sentenza, in commento, Corte giust., 21 dicembre 2023, European Superleague Company, S.L., C-333/21, EU:C:2023:1011, pp.75,82,142.
7 Ha inciso molto, in tal senso, l’avvento della tecnologia digitale e delle Tv commerciali, in lotta per accaparrarsi diritti televisivi, uniti all’aumento esponenziale e alla cadenza regolare degli eventi calcistici lucrativi, nonché al connesso incremento, diretto o indiretto, dei posti di lavoro e dei rapporti pubblicitari e di sponsorizzazione. A tal riguardo si veda B. NASCIMBENE e S. BASTIANON, “Diritto europeo dello Sport”, Giappichelli Editore, 2011, pag.55.
8 L’evento calcistico, complice la contestualità tra la “messa in scena” ed il consumo, nonché l’omogeneità, stabilità e fidelizzazione del pubblico, è divenuto, sempre più, un prodotto commerciale unico nel suo genere, irripetibile e non sostituibile, dunque dotato di un elevato valore di mercato. In tal senso si veda E. LOFFREDO, “L’impresa di spettacoli, anche sportivi”, AIDA (Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo), 2007, pag.318.
9 Finendo per coinvolgere anche imprese diverse da quelle protagoniste del mercato primario, soprattutto nei settori della comunicazione ed informazione, in primis audiovisivi, come evidenziato nella sentenza Superlega, in commento, p.227.
10Sentenza Corte giust., 12 dicembre 1974, Walrave e Koch, 36/74, EU:C:1974:140, pp.4/6.
11Dichiarazione n. 29 sullo sport, allegata al Trattato di Amsterdam, G.U. C340 del 10/11/1997, pag.0136; Relazione di Helsinki sullo sport COM/99/0644 def. del 10/12/1999; Dichiarazione di Nizza del 2000, All. IV delle Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 7-10/12/2000; Libro bianco sullo sport, Bruxelles, 11.07.2007 – COM (2007) 391 def.
12L’AGCOM, IC27, “Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico”, Provv. n. 16280 del 21/12/2006, in Boll. Uff. n. 51-52/2006, Cap.1, par.1 e 3, in cui si sottolinea che il settore calcistico, anche come settore economico, conserva delle specificità rilevanti nei suoi rapporti con le regole di concorrenza, di cui non può non tenersi conto, la prima delle quali “attiene alla necessarietà di un certo grado di interdipendenza e solidarietà tra concorrenti”, tale per cui, “a differenza di quanto accade in altri settori economici, i soggetti che operano nel campo dello sport non perseguono l’obiettivo di eliminare i propri concorrenti”, essendovi, piuttosto, ai fini della stessa esistenza delle competizioni, un “interesse reciproco alla salvaguardia delle capacità sportive ma anche della solidità economica dei concorrenti”.
13In ordine alla eccezione sportiva si veda Corte giust., Walrave e Koch, cit., pp.7/10; Corte giust., 14 luglio 1976, Donà, 13/76, EU:C:1976, pp.12 e 14; Corte giust., 11 aprile 2000, Deliège, cit., pp.41 e 48; Corte giust., 15 dicembre 1995, Bosman, cit., pp.76 e 138.
14Sentenze Bosman, cit., p. 76; Deliège, cit., p. 43; Donà, cit., p. 15; Walrave e Koch, cit., p. 7/10.
15Sentenza Corte giust., 18 luglio 2006, Meca Medina e Majcen/Commissione, C 519/04 P, EU:C:2006:492.
16In contrasto con quanto era stato ritenuto da TPGCE, 30 settembre 2004, Meca Medina e Majcen/Commissione, T-313/02, Racc. pag. II 3291, pp.42,44,47,66, in cui si era esclusa l’applicabilità del diritto della concorrenza.
17Si veda, a tal riguardo, S.M. CARBONE, “Lo sport ed il diritto dell'Unione europea dopo il trattato di Lisbona”, in Studi integrazione europea, 2010, pag.606.
18Conclusioni dell’Avvocato Generale, Athanasios Rantos, presentate il 15/12/2022, pp.34 e 35.
19Sent. Superlega, pp.95-107. La Corte di Giustizia, nella sentenza del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, I-527, ha chiarito che la nuova collocazione sistematica del principio di libera concorrenza nel Trattato di Lisbona, in cui non è più enunciato tra le norme di apertura, non ne altera la valenza sistematica nell’Ordinamento dell’Unione Europea.
20Punti 103 e 104 sentenza Superlega, in commento.
21Articoli 22 e da 71 a 73 dello statuto della FIFA; articoli 49 e 51 dello statuto della UEFA.
22Sentenza Corte giust., 19 febbraio 2002, Wouters e a., C 309/99, EU:C:2002:98, p.46; in seguito Corte giust., 1 luglio 2008, MOTOE, C 49/07, EU:C:2008:376, pp.20 e 21.
23Si veda, ex plurimis, Corte giust., MOTOE, cit., p.22.
24La Corte ha evidenziato come “la circostanza che l’offerta di beni e servizi sia fatta senza scopo di lucro non osta a che l’ente che effettua tali operazioni sul mercato vada considerato come un’impresa, poiché tale offerta si pone in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro”. In tal senso, Corte giust. MOTOE, cit., p.27; ancor prima Corte giust., 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, I-229, pp.122 e 123.
25Partecipano ad eventi lucrativi ed elargiscono prodotti e servizi in vista di ritorni economici. Considerazioni pacificamente condivise, nella causa in commento, dalla Corte di Giustizia, cit., p.115, e dall’Avvocato generale A.Rantos, p.59. Si veda, in tal senso, anche sentenza del Tribunale di primo grado, IV sez., 26 gennaio 2005, Piau/Commissione, T 193/02, EU:T:2005:22, p.69.
26Del resto, ai fini dell’integrazione di tale ulteriore presupposto applicativo, che segna il confine tra la disciplina antitrust comunitaria e quella nazionale, basta che “appaia sufficientemente probabile che siano decisioni atte ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri”, sulla “libertà di commercio” tra gli stessi, come evidenziato in Corte giust., 13 luglio 2006, Manfredi e a., C-295/04 e C-298/04, I-06619, pp.41 e 42.
27Corte giust., 26 novembre 2015, Maxima Latvija, C 345/14, EU:C:2015:784, pp.18 e 19; in tal senso si vedano anche le sentenze Corte giust., 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C 307/18, EU:C:2020:52, p.67; Corte giust., 2 aprile 2020, Budapest Bank e a., C 228/18, EU:C:2020:265, p.36. Vi si può intravedere, dunque, una forma di presunzione di effetti anticoncorrenziali, basata sull’esperienza acquisita.
28Corte giust., 11 settembre 2014, CB/Commissione, C?67/13 P, EU:C:2014:2204, p.53; si vedano anche le sentenze Corte giust., 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione, C?373/14 P, EU:C:2016:26, p.27; Corte giust., Generics (UK) e a., cit., pp.67 e 68; Corte giust., 23 gennaio 2018, F. Hoffmann La Roche e a., C 179/16, EU:C:2018:25, pp.79 e 80. Circa il carattere oggettivo e manifesto degli obiettivi rilevanti si veda Corte giust., 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C 209/07, EU:C:2008:643, p.21; in tal senso anche Corte giust., 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C 551/03 P, EU:C:2006:229, pp.66 e 67.
29Corte giust., 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC), C 1/12, EU:C:2013:127, p.93.
30Corte giust. sul caso Superlega, in commento, pp.143-146.
31Conclusioni Avvocato generale A.Rantos, cit., pp.72 e 73. Nei punti 83 e 84, si aggiunge che solo da un tale esame circostanziato potrebbe emergere come la severità delle sanzioni sia tale da avere, in concreto, effetti dissuasivi, idonei a privare i terzi organizzatori della necessaria partecipazione di club e giocatori.
32Corte giust., MOTOE, cit., pp.49,50,51; si veda anche Corte giust., 13 dicembre 1991, GB-Inno-BM, C 18/88, EU:C:1991:474, p.25; Corte giust., 12 febbraio 1998, Silvano Raso e a., C-163/96, EU:C:1998:54, I-00533, pp.27-31.
33Corte giust., MOTOE, cit., p.52; Tribunale di primo grado, IV sez., 16 dicembre 2020, International Skating Union/Commissione, T 93/18, EU:T:2020:610, p.70.
34Anche se innovative e suscettibili di soddisfare gli interessi di spettatori e telespettatori. Sentenza Superlega, p.176.
35Sentenza Superlega, in commento, pp.177 e 178.
36Sulla nozione di posizione dominante si vedano, ex plurimis, Corte giust., MOTOE, cit., p.37 e giurisprudenza ivi richiamata; Tribunale, II Sez., 6 ottobre 1994, Tetra Pak International SA/Commissione, T-83/91, p.109. Si vedano, inoltre, le conclusioni dell’Avvocato generale A.Rantos, cit., p.36, in cui evidenzia come vi siano stati, negli anni ’90 e 2000, dei movimenti “separatisti” che hanno tentato di creare, in Europa, competizioni concorrenti rispetto a quelle della Uefa, ma non si sono concretizzati. In p.36, n.20, si richiamano i progetti Media Partners e Golden League.
37Corte giust., MOTOE, cit., pp.25 e 26. In tal senso anche Corte giust., 19 gennaio 1994, SAT Fluggesellschaft mbH contro Eurocontrol, C-364/92, EU:C:1994:7, I-00043, pp.24, 28-31.
38Si veda, in tal senso, la posizione espressa, ex plurimis, da J. ZYLBERSTEIN, “La specificità dello sport nell’Unione Europea”, ISSN 1825-6678, Vol. IV, Fasc. 1, 2008, p.66, n.23. A ciò si aggiunga che, nell’Ordinamento italiano, l’inquadramento delle Federazioni sportive nazionali come un giano bifronte, formalmente privato ma sostanzialmente e funzionalmente pubblico, è proseguita in dottrina e giurisprudenza anche dopo la riforma del D.lgs. 242/99, trovando sostegno, ad esempio, nel d.l. 220/2003, da cui si ricava che le Federazioni stesse, pur avendo personalità giuridica di diritto privato, possano intercettare posizioni soggettive di interesse legittimo, esercitando, dunque, pubblici poteri.
39Corte giust., OTOC, cit., p.24; Corte giust., MOTOE, p.24.
40Argomentazioni desumibili, per analogia, dalla sentenza Corte giust., OTOC, cit., pp.46-56.
41Si veda, ex plurimis, Corte giust., MOTOE, cit., p.37 e giurisprudenza ivi richiamata.
42Corte giust., Generics (UK) e a., cit., p.148; nonché sent. Superlega, in commento p.125, e giurisprudenza ivi richiamata.
43Corte giust., 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C 152/19 P, EU:C:2021:238, p.41; Corte giust., Generics (UK) e a., cit., p.154.
44Avvocato generale A.Rantos, cit., pp.133 e 134.
45Sentenza Superlega, pp.137 e 138. Si può ritenere che sia un approccio innovativo, più rigido del passato, come confermato anche dal fatto che, a sostegno dello stesso, la Corte richiama, come unico precedente, la citata sentenza GB-Inno-BM, ossia una pronuncia del 1991 che, in realtà, si limita a riscontrare un abuso nel comportamento dell’impresa che, oltre a detenere una posizione dominante su un mercato, si riservi, senza obiettiva necessità, un’attività ausiliaria su un mercato vicino, ma distinto, con il rischio di eliminare qualsiasi concorrenza da parte di una terza impresa.
46Il quale non è espressione di valori naturali, universali ed immutabili, come dimostra l’esistenza, nel mondo, di altri modelli sportivi, primo tra tutti quello della NBA statunitense (competizione chiusa, a cui la partecipazione è assicurata dal pagamento di un diritto di ingresso, piuttosto che da logiche meritocratiche), rispondenti a principi nettamente diversi.
47Pericolo già evidenziato da G. INFANTINO, ufficio legale Uefa, ora presidente Fifa, “Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport”, pubblicato in data 2/10/2006 in editorial.uefa.com.
48Corte giust., Wouters e a., cit., pp.97, 107-110; altro arresto, sempre relativo ad un ordine professionale, è stato Corte giust., OTOC, cit., p.96; mentre Corte giust., 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione, cit., pp.43-55, rappresenta l’unico precedente in cui la teoria delle restrizioni accessorie è stata applicata in ambito sportivo.
49Ad esempio, l’Avvocato generale A.Rantos, nelle sue conclusioni, cit., pp.101-105, spiega le ragioni per cui tale meccanismo si sarebbe rivelato inerente e proporzionato proprio nell’impedire la Superlega, ritenendola una competizione sostanzialmente chiusa e non meritocratica, a fronte della quale le altre competizioni diventerebbero sostanzialmente irrilevanti, cosicché i membri della Superlega si assicurerebbero un notevole vantaggio competitivo, sia economico che sportivo, nei confronti delle altre società, con cui continuerebbero a gareggiare in ambito nazionale. Ciò diminuirebbe anche i ricavi delle altre competizioni, destinati ad essere ripartiti tra tutte le squadre della piramide calcistica.
50In ordine ai presupposti dell’esimente ex par. 3, sentenze Corte giust., 11 luglio 1985, Remia BV e a./Commissione, C-42/84, EU:C:1985:327, p.45; Corte giust., 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services Unlimited/Commissione, C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P., EU:C:2009:610, p.79; Corte giust., 11 settembre 2014, MasterCard Inc. e a./Commissione, C 382/12 P., EU:C:2014:2201, p.235.
51Come si evince, ex plurimis, da Corte giust., 27 marzo 2012, Post Danmark, C 209/10, EU:C:2012:172, p.42.
52A mutare, semmai, è l’impatto mediatico e, conseguentemente, giuridico, che tali dinamiche generano laddove ad essere interessati siano settori sportivi meno “blasonati” del calcio. Si pensi, ad esempio, al caso, in parte analogo e di sicuro minore rilievo nell’ambito dell’opinione pubblica, dell’Eurolega nel basket.
Email: [email protected]