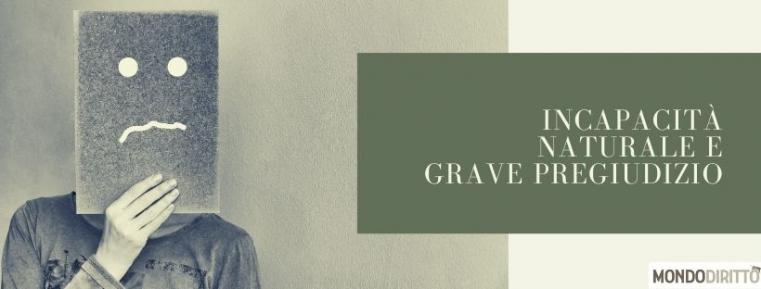Diritto Civile. L'incapacità naturale e il requisito del "grave pregiudizio" richiesto dal comma 1° dell'art. 428 c.c.
Cos'è la capacità giuridica? Cos'è l'incapacità naturale? (A cura dell'Avv. Liliana Rullo)
A cura dell'Avv. Liliana Rullo
_______________
La capacità giuridica è l’idoneità del soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche.
La capacità giuridica è:
- generale, quando il soggetto è astrattamente idoneo ad essere titolare di qualsiasi posizione giuridica tesa a tutelare i suoi interessi;
-speciale quando riguarda determinati rapporti.
Inoltre la capacità giuridica è ridotta quando il soggetto è inidoneo ad essere titolare di una generalità di posizioni giuridiche che potrebbero rientrare nella sua sfera di interessi.
La limitazione o la mancanza della capacità giuridica escludono la possibilità di partecipare al rapporto, infatti chi è colpito da incapacità giuridica non può rendersi titolare del diritto in alcun modo: egli non è per l’ordinamento un soggetto giuridico e no rileva come centro di imputazione.
Quando la persona fisica acquista la capacità giuridica?
La persona fisica acquista la capacità giuridica con la nascita e la conserva fino alla morte.
Anche se sono molteplici le disquisizioni dottrinali sul momento di attribuzione della capacità, la dottrina maggioritaria ritiene la capacità giuridica non graduabile e coincidente con la separazione del feto dal corpo materno.
A tal riguardo notevoli problematiche interpretative ha portato la Legge 19 febbraio 2004 n. 40 sulla procreazione assistita per quanto concerne la posizione giuridica del nascituro non concepito, del concepito e dell’embrione.
La perdita della capacità giuridica si ha con la morte che la Legge n. 578 del 1993 ha identificato nella cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo.
Cos'è la capacità di agire?
La capacità di agire è l’idoneità del soggetto a compiere e ricevere atti giuridici incidenti sulla sua sfera personale e patrimoniale.
La capacità legale di agire si acquista con il raggiungimento della maggiore età.
Tale incapacità deriva dal presupposto stabilito dalla legge, non rilevando l’effettiva situazione del soggetto: infatti gli atti posti in essere dal soggetto incapace sono invalidi anche senza la necessaria dimostrazione della inettitudine psichica del soggetto al momento in cui l’atto è posto in essere: essa fa difetto nel minorenne, all’interdetto, sia giudiziale che legale e all’inabilitato.
Inoltre vi sono persone capaci in generale di provvedere a sé ma al contempo non in grado di valutare in modo adeguato le conseguenze degli atti che vengono posti in essere: tale tipo di incapacità è detta “naturale” o di fatto e può consistere sia in una condizione permanente di incapacità che in una condizione transitoria: essa assume rilevanza non con l’idoneità del soggetto a compiere atti in astratto e in modo generico ma il momento in cui l’atto giuridico viene posto in essere. In particolare ciò che rileva è sé in quel momento sussisteva in capo al soggetto uno stato di inettitudine psichica che avrebbe potuto pregiudicare una valutazione corretta dell’atto: in tal caso l’atto potrebbe essere impugnato e dichiarato invalido.
Dall’art. 1425 c.c. si desume che, qualora ricorrano le condizioni sancite dall’art. 428 c.c., sia l’incapace legale che l’incapace naturale producono la stessa conseguenza con riguardo non solo ai contratti ma anche alla generale attività negoziale posta in essere dall’incapace, ossia l’annullabilità.
Mentre nell’incapacità legale il criterio di determinazione delle cause è normativo, essendo le stesse tassativamente e preventivamente fissate dalla legge, nell’incapacità naturale il criterio è affidato al diretto apprezzamento del giudice e consiste nella verifica della situazione dell’autore dell’atto, che pur non essendo incapace legalmente di agire, si trovi per qualsiasi causa anche transitoria, in una condizione di incapacità di intendere e di volere nel momento in cui l’atto è stato compiuto ai sensi dell’art. 428 c.c.
Inoltre, mentre nell’incapacità legale la legge oltre ad accordare all’incapace una protezione successiva al verificarsi del pregiudizio (annullabilità dell’atto pregiudizievole posto in essere) prevede un sistema di protezione dell’incapace che tende a prevenire il verificarsi di pregiudizi economici, nell’incapacità naturale manca una protezione preventiva dell’incapace e la protezione successiva, ossia l’annullabilità dell’atto pregiudizievole, è condizionata alla prova della gravità del pregiudizio subito dall’incapace e, nel caso di contratti, la prova della malafede dell’altro contraente.
La salvaguardia dell’affidamento della controparte è tutelata anche nel diritto internazionale privato dove criterio generale è quello della lex personae, ossia la capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale, mentre si applica la legge regolatrice dell’atto quando siano previste condizioni speciali di capacità per il compimento di esso.
Il contraente incapace secondo la legge nazionale, ma capace secondo la legge dello Stato in cui il contratto è concluso, può invocare la sua capacità solo se al momento del contratto la controparte lo conosceva o l’ha colposamente ignorata.
L’incapacità naturale non indica dunque uno stato legale d’incapacità ma uno stato di fatto della persona che può essere giuridicamente rilevante.
Si ritiene che essa acquisti giuridica rilevanza come difetto della volontà negoziale.
L’impugnabilità consegue automaticamente alla sola incapacità naturale, senza la necessaria dimostrazione del grave pregiudizio o della malafede dell’altro contraente in alcuni atti “più gravi”: il matrimonio, ai sensi dell’art. 120 c.c., il testamento ex art. 591 c.c. e la donazione ex art. 775 c.c.
Secondo parte della dottrina, quindi, il carattere non patrimoniale dell’atto rende inutile l’applicabilità del requisito del pregiudizio in quanto l’art. 120 c.c. non richiede, ad esempio, per ammettere l’impugnazione del matrimonio da parte dell’incapace naturale, alcun pregiudizio.
L’orientamento dottrinale dominante, al contrario, sostiene che nell’ipotesi in cui sia chiesto, ad esempio, l’annullamento di un negozio familiare (riconoscimento del figlio naturale) non può prescindersi dall’accertare il requisito del pregiudizio che andrà valutato secondo un parametro extrapatrimonaile.
Nell’art. 428 c.c. si è operata una distinzione: negli atti unilaterali per l’invalidità occorre oltre all’incapacità di intendere e di volere anche un grave “pregiudizio” a danno dell’incapace; mentre nei contratti per l’invalidità dell’atto occorre oltre all’incapacità di intendere e di volere anche la mala fede dell’altro contraente .
La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che ai fini dell’annullamento dei contratti posti in essere dall’incapace sia sufficiente la prova della malafede dell’altro contraente, mentre il pregiudizio può rilevare solo come indice rivelatore della malafede stessa.
Dottrina minoritaria ritiene necessario un autonomo accertamento sia del pregiudizio dell’incapace che della malafede dell’altro contraente. Comunque, anche se vi sono incertezze interpretative per quanto riguarda la necessità del pregiudizio nei contratti la giurisprudenza, in precedenza divisa e tendente ad affermare il carattere autonomo del pregiudizio, è orientata nel ritenere tale requisito solo come indizio della malafede dell’altro contraente.
Cosa si intende per pregiudizio?
Il pregiudizio è considerato dalla dottrina maggioritaria come uno svantaggio economico, corrispondente ad una diretta perdita patrimoniale potendosi riflettere comunque sul piano giuridico ed indirettamente su quello economico ad esempio nel caso di un’inutile assunzione di un’obbligazione cambiaria.
A sostegno di tale tesi è data la circostanza che il pregiudizio non è richiesto dagli artt. 591 n. 3 e 775 c.c., i quali essendo negozi di pura attribuzione, attribuiscono al pregiudizio rilievo di natura esclusivamente economica.
Secondo altra autorevole dottrina il grave pregiudizio ex art. 428 c.c. consiste in una grave sproporzione o in un’eccessiva onerosità quando il contenuto è caratterizzato patrimonialmente.
Per quanto concerne il contratto, ridiscute se sia richiesto anche il pregiudizio oltre che alla malafede dell’altro contraente.
A tal riguardo si ritiene che non siano applicabili le regole proprie della buona fede in senso soggettivo: non si prende in rilievo la conoscenza, ma la consapevolezza delle menomazioni intellettive della controparte.
La prova della malafede sarà data da una valutazione condotta con riferimento al pregiudizio subito dall’incapace, insieme alla qualità del contratto e alle circostanze contrattuali (c.d. pregiudizio come indizio).
Nelle ipotesi in cui sia dubbia la natura contrattuale di un atto, come ad esempio nel contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 c.c. la rilevanza delle condizioni di malafede dipenderà dalla natura che all’atto venga attribuita dall’interprete. Infatti secondo autorevole dottrina l’art. 1333 c.c. sarebbe teso a prevedere un modo speciale di conclusione che si situa nel mezzo tra il contratto, che è formazione bilaterale (soluzione accettata dalla prevalente giurisprudenza), e il negozio unilaterale parlandosi di negozio unilaterale a rilievo bilaterale.
Nel caso di incapacità naturale dell’obbligato o di suo errore sulla natura del negozio la soluzione è dubbia. In conclusione può dirsi che la protezione offerta dall’art. 428 c.c. a tutti coloro che per ragioni di salute non siano capaci di intendere e di volere nel momento in cui compiono un negozio giuridico è gravemente carente nonostante la più recente giurisprudenza è stata tesa a sostituire la tradizionale configurazione dell’incapacità naturale come assenza delle facoltà mentali con la sua più elastica definizione di “perturbamento psichico tale da menomare pur senza escludere le facoltà intellettuali del soggetto ed inoltre è stata tesa a precisare che per l’annullamento dei contratti non è necessaria la prova specifica del pregiudizio che costituisce solo un semplice indice rivelatore della malafede dell’altro contraente".
Si è quindi da tempo avvertita l’esigenza di introdurre nuovi strumenti di tutela che affiancandosi all’art. 428 c.c. vadano ad assicurare una diretta e sicura protezione a tutti quei soggetti che sono in uno stato psico-fisico tale da porli in una semplice situazione di inferiorità o di difficoltà nel compimento dell’attività negoziale.
Una direttiva di riforma è stata offerta da una legge francese che nel 1968 ha introdotto un nuovo strumento di protezione che si affianca a quelli tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione, il c.d. “salvaguarde de justice”.
In Italia un primo orientamento di riforma sembra emergere dalla Legge 18/1975 ove è prevista una protezione preventiva del cieco che può farsi assistere da una persona di sua fiducia nella stipulazione di un negozio giuridico.
Nel 2004 si è creato a tale scopo l’istituto dell’amministratore di sostegno, con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, il cui oggetto dell’incarico affidato può estendersi oltre che alla tutela degli interessi patrimoniali anche a tutto quello riguarda la cura della persona del beneficiario e cioè alla soddisfazione dei suoi bisogni di ordine non patrimoniale.
La positiva applicazione di tale istituto è possibile quando la causa dell’inidoneità della persona consista in uno stato interessante la sua sfera psichica, del quale possa prevedersi che evolva nel senso della guarigione entro un determinato arco temporale.
Al contrario l’interdizione e l’inabilitazione richiedono la sussistenza di una psicopatologia.
Incapacità naturale e grave pregiudizio: domande e risposte.
Come deve essere effettuata la valutazione sull'idoneità a recare grave pregiudizio?
Ai fini dell'annullamento degli atti unilaterali per incapacità naturale, l'accertamento dell'idoneità a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuato con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e sulla base di una valutazione "ex ante", nella quale occorre tenere conto di tutte le caratteristiche strutturali del negozio, idonee a disvelarne la potenzialità lesiva. Cassazione civile sez. III, 12 giugno 2020, n.11272
Quale rapporto intercorre tra la sussistenza del grave pregiudizio e il requisito essenziale della mala fede?
Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428, comma 2, c.c., non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del comma 1, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente; quest' ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Peraltro, la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto.Cassazione civile sez. II, 26 febbraio 2009, n.4677
Ai fini dell'annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato d'incapacità naturale, è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per l'incapace; laddove, in concreto, tale pregiudizio si sia verificato, esso tuttavia ben può costituire un sintomo rivelatore di detta malafede.
La Cassazione, con sentenza del 9 agosto 2007 n. 17583, ha ad esempio confermato la decisione del giudice di merito che ha ritenuto a maggior ragione provata la malafede dell'acquirente, dal momento che era stato accertato, mediante consulenza tecnica psichiatrica, espletata nel giudizio relativo all'interdizione dell'alienante, il suo stato di grave infermità psichica irreversibile da etilismo cronico.Cassazione civile sez. II, 9 agosto 2007, n.17583
Il grave pregiudizio ec art. 428 c.c. può riguardare anche interessi di natura non patrimoniale?
Sì. Il "grave pregiudizio" che, ai sensi dell'art. 428, comma 1 c.c., legittima l'annullamento degli atti compiuti in stato d'incapacità naturale, può essere non solo di natura patrimoniale, ma anche pertinente ad interessi di natura non patrimoniale.Cassazione civile sez. lav., 14 maggio 2003, n.7485
Ai fini dell'annullamento del contratto concluso da un soggetto in stato d'incapacità naturale è sufficiente la malafede dell'altro contraente, senza che sia richiesto un grave pregiudizio per il soggetto incapace, pregiudizio che può costituire un mero sintomo rivelatore di detta malafede.Cassazione civile sez. II, 14 maggio 2003, n.7403
Gli tti unilaterali compiuti da un incapace naturale sono nulli oppure annullabili?
Gli atti unilaterali compiuti da un incapace naturale non sono nulli, ma annullabili e solo su istanza della persona che si assume essere stata naturalmente incapace al momento del compimento dell'atto o dai suoi eredi o aventi causa e solo se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. Cassazione civile sez. lav., 30 gennaio 2003, n.1475
Per l'annullamento dei contratti conclusi da un soggetto in stato di incapacità naturale, a differenza che per i negozi unilaterali, non è richiesta la dimostrazione del grave pregiudizio, non costituendo questo in sè un elemento costitutivo e concorrente, ma solo uno degli indizi rivelatori del requisito essenziale della malafede.Cassazione civile sez. II, 2 giugno 1998, n.5402; Cassazione civile sez. II, 26 febbraio 1992, n.2374
______________________
- La valutazione di un bene, che sia stato oggetto di un atto giuridico compiuto da persona incapace di intendere e di volere, al fine di stabilire se ne sia derivato grave pregiudizio all'autore rientra nell'ambito del giudizio di fatto ed appartiene alla competenza propria ed esclusiva del giudice del merito, le cui determinazioni non sono sindacabili in sede di legittimità, se non risultano l'effetto di errori giuridici o di vizi logici. Cassazione civile sez. lav., 17/04/1984, n.2499
- Per l'annullamento del contratto stipulato da un soggetto in stato di incapacità naturale, non occorre la dimostrazione del grave pregiudizio da tale negozio derivante per l'incapace stesso.Cassazione civile sez. III, 11 febbraio 1978, n.619
- Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale, non occorre che dal contratto sia derivato o possa derivare all'incapace un grave pregiudizio, costituendo questo soltanto uno degli indizi rilevatori della malafede dell'altro contraente, intesa come colpevolezza della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del primo. Il caso riguardavaun vitalizio oneroso concluso con persona di età avanzata e colpito da "ictus" cerebrale, deceduta pochi giorni dopo il contratto, la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito, desumendo la malafede del vitaliziante dalla conoscenza delle condizioni di salute del vitaliziato, che rendevano facilmente prevedibile l'imminente decesso di quest'ultimo, abbiano attribuito valore di indizio rivelatore alla "qualità del contratto", dal quale risultava in concreto eliminata l'alea caratteristica del vitalizio oneroso.Cassazione civile sez. III, 11 febbraio 1978, n.619
Email: [email protected]